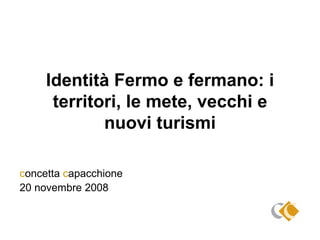IdentitĂ Fermo e fermano: i territori, le mete, vecchi e nuovi turismi
- 1. IdentitĂ Fermo e fermano: i territori, le mete, vecchi e nuovi turismi c oncetta c apacchione 20 novembre 2008
- 2. Ma il modello dei distretti industriali non puĂČ essere ampliato: i distretti culturali, i distretti turistici, i distretti âŠ?
- 3. I distretti industriali Marche Castelfidardo: gli strumenti musicali Fermo: le calzature Montefeltro: il tessile/abbigliamento Pesaro: il mobile San Benedetto del Tronto: l'agro alimentare
- 4. ISTAT sui distretti industriali I distretti industriali sono entitĂ socio-territoriali in cui una comunitĂ di persone e una popolazione di imprese industriali si integrano reciprocamente. Le imprese del distretto appartengono prevalentemente a uno stesso settore industriale, che ne costituisce quindi l'industria principale. Ciascuna impresa Ăš specializzata in prodotti, parti di prodotto o fasi del processo di produzione tipico del distretto . Le imprese del distretto si caratterizzano per essere numerose e di modesta dimensione.
- 5. I distretti industriali PMI Il termine "distretto industriale" Ăš stato utilizzato per la prima volta dall'economista inglese Alfred Marshall, nella seconda metĂ del XIX secolo, per descrivere la realtĂ delle industrie tessili di Lancashire di cui individua le caratteristiche: individuazione di una realtĂ "socioeconomica" presenza di una filiera concentrazione geografica relazioni allo stesso tempo di collaborazione e concorrenza
- 6. I distretti industriali PMI Secondo la Legge italiana, invece, si definiscono distretti industriali, «aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese ». Definizione che, riprendendo quella classica, sottolinea la stretta relazione tra realtà industriale e sociale. Analizzando vari casi si possono indicare una serie di elementi, che hanno favorito la nascita del distretto la concentrazione geografica delle filiere il forte ancoraggio socio-culturale ad un territorio circoscritto la natura reticolare delle strutture organizzative distrettuali
- 7. I distretti industriali PMI nascono, inoltre, rapporti molto stabili , . la specializzazione Ăš la nota caratterizzante i distretti: le industrie sono collegate tra loro da intensi rapporti di sub-fornitura. Dal punto di vista funzionale ed organizzativo questa forma di distribuzione del lavoro favorisce l'efficienza dell'intero sistema di produzione locale limite possibile del sistema dei distretti: le caratteristiche specifiche dei Distretti Industriali possono rappresentano una limitazione al cambiamento evoluzione del sistema dei distretti: un nuovo modo di intendere l'integrazione. Non piĂč, quindi, una netta distinzione tra le fasi di un processo produttivo, ma la crescita di una rete di imprese, non necessariamente concentrate geograficamente, orientate a gestire, in modo integrato i processi di progettazione (codesign), e le fasi produttive (comakership), utilizzando sistemi di codifica comuni e sforzandosi di programmare gli impegni e i carichi reciproci almeno nel breve periodo.
- 8. Una ulteriore evoluzione possibile dei distretti le piattaforme produttive
- 9. Le piattaforme produttive (Aldo Bonomi) I sistemi locali spesso sono realtĂ acefale , prive di una âtestaâ che possa progettare il cambiamento e organizzare il consenso e le risorse necessarie per realizzarle. Per irrobustire le aziende dal punto di vista finanziario, avvicinare la pratica del fare ai saperi della ricerca e dellâistruzione, creare le infrastrutture, gestire lâimmigrazione occorrono decisioni collettive prese da attori collettivi che abbiano la capacitĂ di guardare il sistema nel suo insieme progettandone la trasformazione e intervenendo sui problemi ogni volta che si aprono.
- 10. Le reti, le piattaforme produttive e le geocomunitĂ La piattaforma produttiva (hardwaree) e la geo-comunitĂ (software) sono una rappresentazione degli spazi della competizione nell'Italia produttiva allâinterno della quale interagiscono economie dei flussi ed economie dei luoghi. Nel modello della piattaforma produttiva convivono sistemi d'azione stratificati non chiudibili in perimetri angusti e rigidi, ma aperti a reti lunghe, fino ad arrivare a quelle globali. Le piattaforme prendono forma e si sostanziano dove c'Ăš produzione intenzionale di relazioni strutturate, flessibili ma anche durature, tra attori economici e istituzionali ; dove si mettono in moto percorsi di coalizione attraverso accordi multiscopo , che hanno per oggetto la produzione di risorse di secondo livello , che i localismi non sono piĂč in grado di produrre. .
- 11. Le piattaforme produttive, le reti, e le geocomunitĂ I cambiamenti allâinterno dei sistemi produttivi inducono (consigliano ? obbligano a?) risposte diverse dei sistemi economici e sociali, con lâuscita dai localismi e lâesigenza di nuove istanze come il lobal, il dispositivo territoriale attraverso il quale i soggetti locali cominciano a elaborare strategie di accettazione della sfida globale . Oggi il territorio non coincide piĂč con lâinsieme di risorse culturali e sociali spontanee ereditate dal passato, diventa un costrutto consapevole degli attori sociali , in cui le ereditĂ delle pratiche collettive passate si intrecciano con le volontĂ , le logiche e le culture dei soggetti.
- 12. Le piattaforme produttive, le reti, e le geocomunitĂ In questo senso il luogo Ăš una espressione locale di culture e relazioni distanziate capaci di vivere la simultaneitĂ . E non puĂČ essere la globalizzazione con lâeconomia dei flussi (finanziari, delle merci, informativi, umani) a distruggere luoghi e identitĂ locali: questo accadrebbe se il territorio fosse irrilevante dal punto di vista economico. Lâeconomia globale post â fordista, fondata su modelli a specializzazione flessibile, Ăš un sistema che genera maggiore divisione del lavoro tra i luoghi e maggiore specializzazione di ciascun luogo , perchĂ© premia la ricerca di apporti individuali e non ripetitivi allâinterno dei reticoli globali.
- 13. Le piattaforme produttive, le reti, e le geocomunitĂ CosĂŹ i flussi fanno interagire, connettono economie e societĂ locali. In questo senso la piattaforma produttiva, in questa interazione e connessione tra luoghi e flussi, deve farsi geocomunitĂ , laddove con questo termine s'indica piĂč propriamente il processo di produzione artificiale di reti, relazioni strutturate, accordi in una parola, di governance. Ed Ăš proprio questa auto â governance che puĂČ offrire, permettere, garantire, la possibilitĂ di competere a livello lobal perchĂ© il potere decisionale Ăš nel territorio stesso, non Ăš altrove e non Ăš distratto.
- 14. Le piattaforme: reti transnazionali per il valore locale verso la competizione globale Nella costruzione delle reti transnazionali non vanno persi gli elementi di specificitĂ che hanno sempre contraddistinto le produzioni locali. La valorizzazione delle risorse distintive del locale diventa la condizione per sostenere e qualificare la presenza nella dimensione transnazionale. Anche le imprese piccole e medie possono in questo modo far parte di una catena transnazionale del valore , talvolta a seguito di un leader, talaltra in base a rapporti stabili di scambio c ostruiti tra uguali o pari grado . Insomma, si puĂČ ormai dire che la produzione di valore Ăš un concetto pertinente non piĂč alla singola impresa ma alla catena transnazionale del valore a cui le singole imprese partecipano.
- 15. Le piattaforme: reti transnazionali per il valore locale verso la competizione globale Quello che deve mutare, Ăš il modo di lavorare , l'atteggiamento culturale che le imprese adottano all'interno dei sistemi. Allo stesso modo con cui il grande sistema gerarchizzato della tradizione fordista si rompe in molte business units autonome , ciascuna delle quali cerca un proprio rapporto col mercato e con partner esterni, sviluppando una missione specifica e competenze piĂč esclusive e focalizzate, Nel distretto/piattaforma le diverse unitĂ (imprese ) devono accrescere il proprio patrimonio di conoscenza e di relazioni, senza demandarlo piĂč al sistema complessivo. CosĂŹ il territorio (piattaforme e geocomunitĂ ) lobal diventa soggetto attivo, protagonista del cambiamento di cui si assume la responsabilitĂ economica e sociale di fare societĂ e comunitĂ . E comunitĂ significa appartenenza, lavoro, identitĂ , opportunitĂ , uguaglianza, utopia, sogno, progetto, integrazione
- 16. La marca e la costruzione di mondi possibili
- 17. La marca La marca ha valore quando introietta e trasmette forti valori. La marca Ăš un sistema dinamico in continua evoluzione e fortemente interconnesso come una piramide, allâinterno della quale si trovano (partendo dal basso) visibilitĂ , competenza e fiducia attributi tangibili, caratteristiche oggettive e performative, i valori dâuso, le esperienze pregresse, ma anche il patrimonio di associazioni e simboli che evoca, lâimmagine, il percepito valutazione dei valori dâuso, soddisfazione e preferenze, ma anche emozioni, sentimenti e affettivitĂ relazione reale con il pubblico: fedeltĂ , empatia, identificazione, commitment, comunicazione al centro della piramide : lâessenza della marca: il suo DNA, il patrimonio genetico e fondativo come viene percepito dal pubblico G.P. Fabris, valore e valorid ella amrca, Franco Angeli, 2004
- 18. Cosa Ăš una marca La marca Ăš un sistema complesso e multidimensionale e funziona come un testo letterario o come qualsiasi altra opera di creazione: costruisce mondi possibili I materiali, i pezzi di cui Ăš fatta una marca sono: nomi, colori, suoni, concetti, oggetti, sogni, desideri. Il risultato del montaggio, lâassemblaggio dei pezzi Ăš un universo ordinato, strutturato, interpretabile e in una certa misura attraente . Quale Ăš la vera identitĂ della marca ? Quella del top management che delinea le strategie, della comunicazione che costruisce i messaggi, quella percepita e veicolata dellâarea commerciale, o quella della distribuzione oppure infine quella del cliente? Andrea Semprini, Marche e mondi possibili, Franco Angeli, 1993
- 19. Le diverse nature della marca La marca Ăš relazione perchĂ© trasmette, comunica discorsi e messaggi e come tutti i processi di comunicazione la ricezione e lâinterpretazione del ricevente sono sottomessi a molteplici modifiche intersoggettiva perchĂ© Ăš in movimento continuo tra i due poli (emittente â ricevente) e quindi tra diversi punti di vista solo la confluenza tra i due diversi poli Ăš il vero generatore della marca contrattuale perchĂ© sollecita lâadesione e lâaccettazione ai mondi che crea, che sono in competizione tra loro e quasi mai si indirizzano a tutti indistintamente (infatti in un certo senso selezionano i loro abitanti) entropica perchĂ© non si autoalimenta, come gli oggetti del mondo naturale, ma deve essere continuamente alimentata dallâesterno, come i costrutti culturali ( fattori che accelerano lâentropia sono la concorrenza, lâincapacitĂ di capire i cambiamenti di cultura dei suoi pubblici ; fattori che decelerano sono la forte affezione dei pubblici, precisione chiarezza e coerenza dei messaggi/discorsi)
- 20. A cosa serve creare un marchio 1. come valore di identitĂ I vantaggi di avere un nome: identifica unâazienda, un prodotto, un servizio, un sistema orienta il cliente Ăš garanzia di qualitĂ per tutta la filiera semplifica lâacquisto o la fruizione entra nei mercati e posiziona aziende, prodotti, servizi, sistemi aiuta a sviluppare e a veicolare di una realtĂ imprenditoriale o di un sistema lâimmagine, la fedeltĂ e la relazione con clienti e consumatori
- 21. A cosa serve creare un marchio 2. come valore di senso I vantaggi di trasmettere significati perchĂ©: identifica uno stile di vita e veicola messaggi e valori si costruisce con codici, simboli, procedure e rappresentazioni fa giocare il cliente/ ricettore con i sogni, i desideri, le aspirazioni trasformandoli in icone, leggende, miti personalizza lâidentitĂ del cliente nel sociale crea una comunitĂ aggregando chi crede in un determinato pensiero entra nel mercato della marca e si posiziona per comportamenti, usi e costumi dei suoi clienti
- 22. A cosa serve creare un marchio 3.come valore economico I vantaggi competitivi della marca: crea e incrementa la fedeltĂ permette maggiori volumi di vendita migliora la relazione con i clienti facilita lâaccesso alla commercializzazione migliora le relazioni nei sistemi crea unâimmagine sfruttabile in tutti gli ambiti giĂ esistenti e nei nuovi migliora la visibilitĂ dei prodotti/servizi nei punti di vendita riduce lâintensitĂ competitiva
- 23. La marca come comunicazione
- 24. Il processo di comunicazione secondo Roman Jakobson (1958) Roman Jakobson analizza il processo di comunicazione evidenziando soprattutto contesto e codice (v. Le parole della comunicazione) contesto messaggio emittente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - destinatario canale - aria, televisione, cavo telefonico, carta codice - le parole, i segni, i segnali, i simboli feed back
- 25. LâidentitĂ di marca Una marca Ăš afferrabile e osservabile solo attraverso la sua identitĂ . La sua identitĂ Ăš il risultato di un gioco complesso di trasmissione di un messaggio , che puĂČ assumere una sua autonomia di significato dopo che Ăš stato emesso, tra un emittente , condizionato fortemente dal contesto e dal suo destinatario, e un ricevente che ha una larga autonomia di elaborazione nellâinterpretazione del messaggio. La dialettica tra il sistema di produzione e il sistema di ricezione, tenuto conto del contesto produce lâidentitĂ di una marca.
- 26. LâidentitĂ di marca Dal punto di vista dei significati lâidentitĂ di marca Ăš data dallâinterrelazione continua tra Enciclopedia della produzione : cultura e valori, obiettivi a breve e lungo termine, mix di comunicazione â logo, pubblicitĂ âŠ), visione del contesto del mercato, visione del contesto socio â culturale, prefigurazione dellâenciclopedia della ricezione e del contesto Contesto: contesto sociale, culturale, politico, economico, contesto di mercato, legislazione, concorrenza, modifiche apportate alle 2 enciclopedie. Enciclopedia della ricezione: atteggiamenti e motivazioni, valori, sensibilitĂ socio â culturali, pratiche di consumo, messa in contesto della marca, interpretazione dellâenciclopedia della produzione, percezione dellâenciclopedia della ricezione.
- 27. Le risorse della marca Lâattribuzione delle proprietĂ allâidentitĂ di amrca Ăš frutto dellâincontro di tutti i tre attori del sistema generativo dellâidentitĂ : CredibilitĂ : nasce dalla coerenza di linguaggio, di promesse e attese dei pubblici LegittimitĂ : Ăš determinata dalla continuitĂ nel tempo e dal dispiegamento nello spazio della sua presenza (quindi Ăš legata ai comportamenti dellâemittente) AffettivitĂ : Ăš la carica affettiva che nel contratto con il destinatario Queste proprietĂ sono risultanti di prove imprescindibili (lancio e presenza sul mercato) e non un programma dâazione.
- 28. Ma perchĂ© diventare marca? La costruzione della marca Ăš lo strumento che permette di rendere indipendente la realtĂ su cui si sta lavorando da sovrapposizioni, personalizzazioni, interferenze, appropriazioni indebite ⊠diventare un vincolo forte e ricco di contenuti per il futuro raccogliere il patrimonio di azioni, pensieri e valori della realtĂ in esame tramandare questo patrimonio indipendentemente dallâazione dei singoli beneficiare di un vantaggio aziendale, economico e semiotico
- 29. I marchi si vendono le marche no I marchi hanno un valore simbolico e grafico. Le marche sono identitĂ complesse, mondi che giorno dopo giorno acquistano valore semantico ed economico e si alimentano della cultura dâimpresa, costruita dalle persone che lavorano, operano, pensano, decidono per la marca (e i suoi prodotti/servizi) Nelle vicende di fusioni, acquisizioni, di cambiamenti quello che si puĂČ acquisire Ăš il marchio, ma non la marca. Questo dĂ alla marca un grande valore.
- 30. Una marca di successo Una marca, per essere di successo, deve raccogliere trasformare veicolare cultura ed etica, valori e conoscenze indipendentemente dalle persone un libro che racconta storie un decalogo cui riferirsi un protocollo da rispettare un modello per costruire relazioni umane
- 31. La costruzione dellâidentitĂ di marca
- 32. La costruzione dellâidentitĂ di marca Il percorso di generazione del senso di una marca, della sua narrazione prevede tre livelli Il livello assiologico: il livello di partenza, il piĂč profondo, che Ăš costituito dai valori fondamentali, i valori di base (vita/morte, giusto/ingiusto, felicitĂ /infelicitĂ ) livello narrativo: Ăš il livello intermedio, dove i valori di base vengono organizzati come racconti o narrazioni, permettendo di rendere i valori della marca espliciti nel racconto (scelta del genere in cui raccontare la storia, attribuzione dei ruoli) livello discorsivo: Ăš il livello di superficie in cui i valori e la narrazione trovano la raffigurazione nei temi, negli attori, nei personaggi, negli oggetti, negli spazi, nei tempi, nella retorica, negli stili
- 33. Il caso Leviâs fino al 1990 livello di superficie: sguardi, seduzione, lâuomo svestito, corpi belli e sensuali, il calore, gli anni â50, la provincia americana livello narrativo: lâesclusione, la sfida, struttura polemica, narrazione realistica livello assiologico: adultitĂ virile, libertĂ , anticonformismo
- 34. La narrazione come racconto delle identitĂ (individuali, di marche, imprese, territori)
- 35. Andare per storie: la narrazione â Quando câĂš un prodotto identico ad un altro ci sono vari modi per vincere la concorrenza: o si abbassa il prezzo (ed Ăš la soluzione piĂč stupida - o si cambia il valore del prodotto raccontando la sua storia â. Barbara B. Stern, What does brand mean, Journal of the Academy of Marketing Science, 2006. Le storie parlano di identitĂ emozioni esperienze conoscenze visioni del mondo anima (delle persone, dei luoghi: genius loci)
- 36. Andare per storie: la narrazione Le storie diventano racconto quando danno luce e voce a i protagonisti, gli attori che hanno svolto un ruolo nella realizzazione di un progetto (aziendale, territoriale, marca âŠ) le azioni che hanno compiuto, rendendole simboliche, esemplari i contesti nei quali si sono svolte le azioni i tempi delle azioni
- 37. Le storie e le emozioni Le storie sono tante : tutte quelle che raccontano i diversi protagonisti con i loro diversi punti di vista. Le storie vanno condivise perchĂ© fanno comunitĂ , sviluppano comunicazione, innovazione e cambiamento. La storia diventa una: perchĂ© si codificano le diverse storie crea il modello narrativo costruisce il senso dellâorganizzazione, del territorio âŠ
- 38. Un poâ di metodo: il testo narrativo e le sue regole
- 39. Il testo narrativo Lâautore Ă lâemittente di un tipo di comunicazione non biunivoca, Ăš lâinventore il costruttore della narrazione. Ă lui che sceglie cosa contiene il testo e come Ăš scritto, cioĂš il contenuto e la forma. Il contenuto Ăš sia la storia con i relativi personaggi e ambientazione spazio - temporale, sia i temi affrontati e lâottica in cui sono raccontati. Le forme sono le scelte linguistiche, i modi enunciativi, le tecniche narrative, il punto di vista e anche il genere. Lâautore non coincide sempre con il narratore, perchĂ© questâultimo ruolo puĂČ essere sostenuto da uno dei personaggi stessi della storia. Il lettore in questa comunicazione non biunivoca puĂČ informarsi raccogliendo informazioni nei dati bio - bibliografici, in storie della letteratura o enciclopedie, anche on line.
- 40. Il testo narrativo La trama La trama Ăš il dipanarsi della narrazione, lo svolgimento dei fatti e il susseguirsi delle emozioni che costituiscono il tessuto del testo. Il titolo Ăš il riassunto dei riassunti. La segmentazione della trama avviene su tre direttrici: fatti e/o emozioni che riguardano i personaggi principali cambiamenti di luogo cambiamenti di tempo Le due strutture del testo narrativo sono : la storia Il racconto
- 41. Il testo narrativo La storia Ă lo schema narrativo grezzo, la serie degli avvenimenti disposti in senso temporale Il racconto o intreccio Ăš la manipolazione della disposizione temporale secondo la particolare ottica narrativa dellâautore, cioĂš come noi lettori troviamo i fatti nel testo.
- 42. Il testo narrativo I personaggi Sono i motori della storia, sono coloro che vivono le avventure e provano le emozioni di cui si parla. Di loro si puĂČ fare una descrizione sia fisica che psicologica. Esistono un protagonista, un eroe, un oppositore e degli aiutanti dellâuno e dellâaltro. I ruoli determinano le relazioni, che sono di opposizione o di vicinanza, di rivalitĂ , di incompatibilitĂ , oppure legami affettivi, solidarietĂ , amicizia e amore . Nel corso della narrazione puĂČ avvenire che le relazioni cambino. Esistono anche figure di doppio: il gemello, il sosia, lâalter ego, oppure del tutto opposte. Nei romanzi moderni spesso il protagonista Ăš lâanti - eroe: fragile, nevrotico
- 43. Il testo narrativo Il personaggio puĂČ rappresentare il punto di vista, inteso sia come angolazione sotto cui Ăš presentata la storia e gli altri personaggi, che come incarnazione delle idee dellâautore (punto di vista ideologico) Dal momento che la narrazione ha una scansione temporale il personaggio puĂČ subire mutamenti, trasformazioni, evoluzioni o Involuzioni , ma anche semplicemente modificazioni legate al passare degli anni e al susseguirsi delle fasi della vita. Oltre che tra loro e con il tempo i personaggi hanno anche relazioni con i luoghi , che possono essere di opposizione o di vicinanza, ossia di contrasto o di di affinitĂ , ma anche di neutralitĂ affettiva.
- 44. Il testo narrativo Lo spazio (i luoghi) Lo spazio in cui si svolge la storia non Ăš un elemento accessorio, ma necessario : Ăš una delle coordinate cartesiane, insieme al tempo , che inquadrano le vicende. Le indicazioni di luogo possono essere date immediatamente o sparpagliate in modo frammentario e rapido, come pezzi di un puzzle, oppure alcuni autori raccontano gli spostamenti, per cui i luoghi sono come tappe di un itinerario di cui si puĂČ ricostruire la mappa.
- 45. Il testo narrativo Il tempo (i tempi) Narrare Ăš unâarte temporale che ha un prima e un dopo . Lo scrittore ha in mente una certa scansione delle vicende, che chiameremo ideale, cioĂš la storia che si snoda con linearitĂ Cronologica. Nel racconto puĂČ mantenere questa linearitĂ oppure puĂČ modificarla, per anticipare (anticipazioni, prospettive) fatti che accadranno dopo, o inserire qualche cosa che Ăš giĂ accaduto e che ritorna alla memoria e deve essere menzionato perchĂ© si possa capire (ricordi, flash back, cioĂš le retrospettive)
- 46. Il testo narrativo Il tempo (i tempi) La storia ha sempre un andamento lineare , cronologico. Il racconto puĂČ rispettare la sequenzialitĂ cronologica oppure presentarsi con un andirivieni di prima e dopo ( a mosaico ), o privilegiare le prospettive o le retrospettive . Lâarco di tempo in cui si sviluppa la narrazione Ăš la durata . PuĂČ essere esteriore (racconti di avventure) o interiore (racconti psicologici); puĂČ riguardare molti anni, come un giorno solo o pochi istanti. Il tempo indica anche il periodo storico in cui si svolgono le vicende: puĂČ essere espresso chiaramente oppure desunto da altri elementi (usi e costumi, oggetti relativi a unâepoca,âŠ). Il tempo puĂČ essere il soggetto della narrazione nei romanzi storici
- 47. Il testo narrativo La forma Il testo narrativo essendo scritto Ăš esposto attraverso lâuso della lingua, quindi ha un lessico una sintassi particolari varietĂ (dialetto, gerghi,âŠ) punteggiatura Il linguaggio del testo Ăš sempre corretto anche se sgrammaticato privo di punteggiatura, perchĂ© Ăš il linguaggio dellâautore, quindi frutto di sue scelte motivate da precise esigenze legate alla trasmissione dei contenuti e alla creazione. Ogni testo Ăš sempre connotato, quindi lâeventuale sostituzione dei termini lo snaturerebbe, perchĂ© ogni parola ha la sua pregnanza.
- 48. Il testo narrativo Il punto di vista Di fronte al dialogo e al discorso indiretto che riporta fedelmente il dialogo, il lettore si fa unâopinione attraverso quello che dicono le battute, quindi i personaggi: il lettore Ăš fuori . Nel racconto in prima persona (io) il lettore Ăš coinvolto nei ragionamenti e nelle mozioni di chi parla, vede le cose con lui: Ăš dentro. Nel racconto in terza persona il lettore potrebbe essere dentro o fuori.
- 49. Il testo narrativo Tecniche narrative Lo scrittore non Ăš solo n inventore di storie, ma anche un tecnico, uno specialista che si serve di strumenti del mestiere, con cui accompagna e orienta il lettore in percorsi di lettura. io narrante (autobiografie, diari, memorieâŠ) monologo interiore (parla un solo personaggio che filtra la realtĂ con la sua prospettiva) flusso di coscienza (come il precedente ma in terza persona) lâintervento diretto dellâautore (che mostra i suoi personaggi come se fossero sue creature e declina tempi e spazi come sue invenzioni) la storia nella storia (una narrazione funge da raccordo allâinterno della quale si inseriscono altre storie) il manoscritto ritrovato (lâautore simula il ritrovamento di un testo scritto da altri e questo conferisce maggiore oggettivitĂ )
- 50. ⊠e ora troviamo una o le tante storie da raccontare ⊠(identitĂ , piattaforma, marca, âŠ)