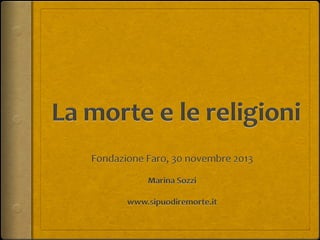La pluralità religiosa
- 2. Vogliamo parlare delle CONCEZIONI o gli atteggiamenti della morte in ogni religione? Mettendole a confronto? Pi√π concretamente, ci poniamo il problema di come comportarci con persone di religioni differenti dalla nostra? Ci stiamo chiedendo quali RITI di morte sono propri alle maggiori religioni? Cosa vorremmo sapere quando ci chiediamo in che rapporto sta la morte con le religioni? Ci interessano le visioni del±Ù‚Äôa±ÙªÂæ±±Ù√†? O pi√π in generale del regno dei morti o degli antenati? Ci interroghiamo sul tema: da dove nascono le religioni? Ipotizzando che siano fondate sulla paura della morte?
- 3. Il tema centrale Soven t prepa e gli opera to ra appar ti alla rela ri non son zione o tiene a cu lt c propr ure di on chi ia. verse dalla  Come possiamo, a prescindere dalla nostra conoscenza di altre religioni, confrontarci comunque con coloro che non appartengono alla nostra.  DOBBIAMO ESSERE CONSAPEVOLI DELLA COMPLESSITA’.
- 4. La complessità Religione Usanze Provenienza geografica Storia collettiva Esperienza di migrazione Sistema personale di valori Esigenze sincretiche
- 5. Le religioni si evolvono nella storia  Il funerale cristiano si è evoluto nella storia. In epoca moderna insisteva sulla tematica del memento mori, oggi tende a consolare il dolente, a non ferire l’uomo che piange, come è esplicitamente detto nel “Rito delle esequie”, già dal 1974
- 6. In genere le religioni aiutano gli uomini a confrontarsi con la realt√† della morte Cristianesimo: Cristo ha accettato la morte e ha portato la vita eterna a tutti gli uomini. Islamismo: la morte fa parte del disegno di Dio, e come tale va accettata: la promessa riguarda anche qui ±Ù‚Äôa±ÙªÂæ±±Ù√†. Ebraismo: la morte fa parte di un disegno immutabile, non occorre chiedersi perch√©, ma osservare le regole. L‚Äôinduismo: l‚Äôanima √® destinata alla fusione con il Tutto, il Brahman, principio divino assoluto. Buddhismo: la morte fa parte della natura delle cose: occorre prepararsi alla quiete assoluta, al Nirvana, allontanandosi dai desideri, per interrompere la catena delle reincarnazioni.
- 7. Piemonte: qualche dato, 2010 Comunità sul territorio: 1. romena (33%) 2. marocchina (17%) 3. albanese (12%) 4. cinese (10470 Piemonte, 4601 a Torino, 3%) 5. peruviana (prima della cinese a Torino, 7500 ca., soprattutto donne, lavoro domestico e di cura, 3%)  30% ALTRI (moldavi, macedoni, russi, eccetera)
- 8. La comunità romena  Circa 50.000 romeni a Torino (la prima comunità straniera).  Ortodossi in buona parte, molti di loro aderiscono alle Chiese avventiste, che negano l’esistenza di un’anima immortale e attendono il secondo avvento di Cristo (meno drammaticità e significato alla morte, attesa del giorno del giudizio). IN ENTRAMBI I CASI, MOLTO IMPORTANTE E’ LA DIMENSIONE COLLETTIVA DELLA MORTE E DEL LUTTO. Gruppi di preghiera visitano i malati e i dolenti sia tra gli ortodossi che tra gli avventisti.
- 11. Quali i problemi in Italia? 1. La diffusa negazione della morte. Nb: Le difficoltà delle assistenti familiari. 2. Il feretro per legge non può essere aperto durante in trasporto. 3. Sovente non è possibile rispettare i tre giorni di veglia, per gli orari nelle camere mortuarie e per la ristrettezza degli ambienti domestici. C’è una mancanza di spazio in città. 4. In genere, con numerose eccezioni, i romeni preferiscono rimpatriare le salme, e celebrare i funerali in Romania. Il costo è di 3000/6000 euro. 5. Il problema del feretro chiuso non viene risolto dal rimpatrio.
- 12. Funerali ortodossi In un villaggio romeno
- 13. + Funerale di George Tudor a Perugia Un giovane quindicenne annegato nel Tevere.
- 14. La morte nell’Islam  Nel Corano si parla molto di più dell’altra vita che della morte stessa. La morte, come la vita, viene da Dio, fa parte di un movimento che ci sovrasta: è un’esperienza che non ha per i musulmani un valore concettuale di particolare rilevanza, né provocare riflessioni prolungate e tormentose.  Il credente sa che ogni aspetto dell’esistenza umana è stato preordinato da Dio, secondo un disegno che l’uomo non potrà mai conoscere, né modificare o annullare.  La morte sarà quindi accolta in spirito di ragionevole e fiduciosa accettazione.
- 15. L’Islam: passaggi rituali 1. Il morente, con la famiglia intorno, recita la professione di fede, col corpo orientato verso la Mecca. 2. Il lavaggio rituale: con acqua tiepida a secchi, sapone, profumi, effettuato tre volte, da persone dello stesso sesso, musulmane, o da un congiunto (purificazione e appartenenza alla comunità religiosa. 3. Il corpo lavato è avvolto in un numero dispari di lenzuola (da tre a sette) 4. Il corpo preparato viene portato in Moschea per le preghiere, recitate da un imam. Le donne non possono partecipare al funerale (divieto del pianto) 5. Si va al cimitero per l’inumazione, portando il defunto su una barella, senza bara (entro le 24 ore). La fossa deve essere profonda due metri.
- 16. Tradizioni popolari del contesto marocchino, diverse in ogni contesto. I marocchini presenti in Piemonte provengono dalla zona di Khouribga, 120 km a sud di Casablanca. Una cerimonia in cui si serve cibo preparato dalle donne del vicinato e gli uomini si occupano del the. Rinsalda i legami sociali, è una rielaborazione simbolica del lutto. Accresce il merito spirituale del morto
- 17. 1. Il morire: dove? La famiglia, può essere presente? 2. Il lavaggio rituale e le camere mortuarie dell’ospedale. 3. L’esigenza che il corpo sia toccato solo da persone musulmane dello stesso sesso. 4. La sepoltura: rimpatrio o sepoltura islamica in Italia? Il denaro. 5. Documenti, organizzazione del trasporto e deritualizzazione. 6. La moschea e lo spazio di preghiera. L’imam? 7. Il cimitero islamico comunale (es. Alessandria e discussioni in altre città). 8. L’obbligo della bara. 9. La cena del morto: viene fatta ma in tono minore.
- 18. M igr az ion e POI CI SONO LE PERSONE, CON LE LORO STORIE E SPECIFICITA’
- 20. Mancanza della dimensione comunitaria del rito Esigenza di porre un punto finale all’esperienza migratoria, reintegrando il migrante nella sua comunità DIFFUSA SCELTA DEL RIMPATRIO
- 21. Lo Zhehijang Provincia povera, grande come l’Italia. In ogni famiglia vi è stato, in passato almeno un individuo che è emigrato. Grazie a questo stato di cose, oggi la zona si è arricchita. Vicino a Shanghai.
- 22. Luoghi comuni I cinesi sono immortali? Nascondono i loro morti per riciclare i passaporti???? Improvvisano camere ardenti clandestine?
- 23. La lettera di Associna ‚ÄúIn Cina il funerale √® evento sacro e viene accompagnato da solenni rituali tipici della tradizione cinese. Tuttavia, il funerale cinese √® una cerimonia che non viene praticata in Italia per diversi motivi. Uni di questi √® rappresentato dalla difficolt√† nell‚Äôorganizzare un momento del genere in terra straniera affrontando, nel dolore, inevitabili problemi di carattere linguistico e burocratico. Un altro motivo che ci spinge a contenerci √® il timore di un possibile scontro con la comunit√† ospitante, di fronte a un rituale cos√¨ invasivo, fatto di lunghe preghiere, marce su strada accompagnate da bande musicali, frastuono di petardi, focolai di ‚Äúdenaro del±Ù‚Äôa±ÙªÂæ±±Ù√†‚Äù che secondo le usanze cinesi portano benessere nella vita ultraterrena etc. ‚ÄúIl fatto che vi sia un esiguo numero di decessi di cittadini cinesi trova spiegazione in fattori culturali e fattori oggettivi. (‚Ķ) abitudine diffusa tra gli immigrati di prima generazione di tornare nella propria terra d‚Äôorigine per trascorrere gli ultimi anni della propria esistenza‚Äù ‚Ķ‚Äùbassa et√† media della popolazione cinese in Italia‚Äù ‚Äúoltre alla vecchiaia, come per tutti gli esseri viventi, si muore anche a causa di incidente o malattia. In questo caso, dove per ovvie ragioni non √® stato possibile il rimpatrio preventivo, le ancora poche persone decedute prendono dimora nei cimiteri italiani‚Äù
- 24. I CINESI, LA BUONA E LA CATTIVA MORTE LA BUONA MORTE LA CATTIVA MORTE  La buona morte: in tarda età, a casa (meglio se nel proprio Paese), a occhi chiusi, nel proprio letto, circondati dai familiari (figli e nipoti), che spesso cantano, avendo terminato i doveri della vita.  La cattiva morte: improvvisa, traumatica, prematura; in Paese straniero, senza commiato dai propri cari. La morte per cancro è CATTIVA, porta sfortuna.  La cattiva morte è causa di sfortuna per la famiglia e può essere attribuita a colpa o all’avversione degli antenati.  Le morti in Italia sono dunque prevalentemente cattive…
- 25. I cinesi, la malattia, la morte, l’ospedale Non utilizzare termini diretti, morte, morente, e neppure CANCRO. E IL CONSENSO INFORMATO? CAUTELA E MEDIATORI CULTURALI. Per pietà filiale, non bisogna comunicare una diagnosi infausta al paziente, l’interlocutore è la famiglia e non l’individuo.
- 26. In Cina, nel passato Rito imponente e molto elaborato: ingenti somme di denaro, simbolo di status. Abiti nuovi per il defunto, tre giorni di veglia, pianto (anche piangitrici), tavoletta con il ritratto del morto, lungo corteo funebre, musica, fiori, petardi, soldi finti e altri oggetti in carta, inumazione o cremazione, periodo di lutto dei parenti. Per la cerimonia si stabilisce giorno e ora propizia. In Cina, oggi Semplificazione del rito e del periodo di lutto (specialmente nelle città). Le tradizioni si seguono meno, si crema (e si seppelliscono le ceneri), nelle città i petardi sono vietati, non si rispetta il mese di lutto. In Italia Frequente semplicità dei riti funebri. Talvolta si accetta un prete cattolico che dia la benedizione al cimitero e l’anima possa trovare la pace. Manca, comunque, una riflessione sui riti, su come farli in Italia. E’ mantenuta l’usanza di scegliere l’ora e il giorno della sepoltura. C’è comunque una grande varietà di atteggiamenti e molto spirito di adattamento.
- 27. + Bolzano, morte di un ristoratore ucciso sull’Autostrada da un uomo che veniva contromano.
- 28. Bolzano, sala del Commiato
- 29. Il discorso del figlio
- 30. Le offerte per ±Ù‚Äôa±ÙªÂæ±±Ù√†
- 31. I soldi finti bruciati
- 32. Il bianco, colore della morte
- 34. E allora? ASCOLTO ATTIVO! Accompagnare persone appartenenti a religioni diverse non è diverso dall’accompagnare i nostri correligionari Quanti laici nella nostra cultura? Quanti individui hanno abbracciato il buddismo?
- 35. Cosa possiamo fare perché la morte sia, per quanto possibile, una buona morte? L’ascolto attivo si basa sull’empatia e sull’accettazione. Si fonda sulla creazione di un rapporto positivo, in un clima in cui l’interlocutore si senta compreso e non giudicato. Chi ascolta non deve essere un “osservatore’’ neutrale ! Occorre comprendere anche le proprie emozioni di fronte a ciò che l’altro dice. L’ascolto deve essere aperto e disponibile verso l’altro e verso se stessi, per ascoltare le proprie reazioni, per essere consapevoli dei limiti del proprio punto di vista e per accettare il non sapere e la difficoltà di non capire.
- 36. + L’ascolto e il silenzio… Carlo Bertocci, Tra ascolto e silenzio, 2010
- 37. Il buon ascolto I principali elementi che caratterizzano una buona attività di ascolto, sono: sospendere i giudizi di valore, non definire a priori il senso. osservare ed ascoltare, ricordando che il silenzio aiuta a capire . mettersi nei panni dell’altro verificare la comprensione, fare domande aperte Curare l’ambiente in cui si svolge la comunicazione per far sentire l’interlocutore a proprio agio.
- 38. Quel che non bisogna fare… - dare ordini - mettere in guardia - moralizzare - persuadere con la logica - elogiare - ridicolizzare - interpretare - consolare - cambiare argomento
- 39. + Le Regole dell’Arte di Ascoltare, 1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi.
- 40. Le Regole dell’Arte di Ascoltare, 2.  Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze.  Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione interpersonale. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti.
- 41. Grazie per la vostra attenzione!