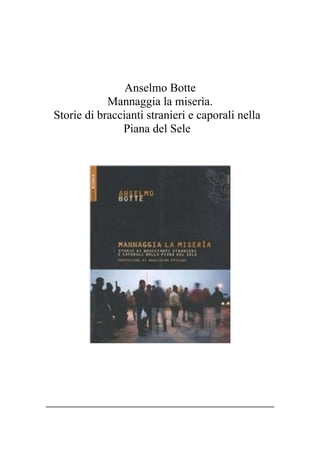Mannaggia la miserìa. Storie di braccianti stranieri e caporali nella Piana del Sele - Anselmo Botte
- 1. Anselmo Botte Mannaggia la miserìa. Storie di braccianti stranieri e caporali nella Piana del Sele
- 2. Titolo: Mannaggia la miser├¼a. Storie di braccianti stranieri e caporali nella Piana del Sele Autore: Anselmo Botte Editore: Ediesse Pubblicazione: Aprile 2009 Pagine: 160 Biografia Anselmo Botte ├© nato a Barile (Pz) nel 1953. Ha aderito al gruppo politico extraparlamentare del Manifesto ed ├© stato tra i protagonisti del movimento studentesco del ŌĆś77, partecipando allŌĆÖoccupazione dellŌĆÖUniversit├Ā. Nel 1980 si ├© laureato discutendo una tesi sperimentale sullŌĆÖanalisi delle classi sociali in agricoltura, relatore prof. Enrico Pugliese. Ha svolto una delle prime ricerche sul campo sulla presenza degli immigrati in Campania. Per alcuni anni ha lavorato nei laboratori di ceramica di Vietri sul Mare, nelle fabbriche conserviere dellŌĆÖAgro Sarnese-Nocerino e in quelle metalmeccaniche del bresciano. Alla fine degli anni ŌĆś80 ├© stato tra gli organizzatori del movimento dei disoccupati di Salerno: suo ├© il progetto di assistenza domiciliare agli anziani che ha trovato uno sbocco occupazionale per centinaia di disoccupati. Nel 1988 la Cgil di Salerno gli affida la responsabilit├Ā della direzione del C.I.D. (Centro Informazione Disoccupati). LŌĆÖanno successivo entra nella segreteria della FLAI (Federazione Lavoratori dellŌĆÖAgro Industria), nella quale rester├Ā, con diversi incarichi, fino al 2009, quando verr├Ā eletto nella segreteria della Camera del Lavoro di Salerno. Mannaggia la miser├¼a. Storie di braccianti stranieri e caporali nella Piana del Sele ├© il suo primo libro. Abstract ┬½Mannaggia la miser├¼a┬╗, con lŌĆÖaccento sulla seconda ┬½i┬╗, ├© unŌĆÖimprecazione ricorrente tra gli immigrati marocchini che vivono nel ghetto di San Nicola Varco, un mercato ortofrutticolo abbandonato nel cuore della Piana del Sele, vicino a Salerno. In quel mercato non si comprano n├® si vendono i prodotti della terra. CŌĆÖ├© altra merce. Ci sono braccia, tante braccia. Con un linguaggio teso e una narrazione incalzante il testo denuncia le condizioni di vita e di lavoro estremamente degradate di un nucleo di settecento immigrati marocchini occupati in agricoltura. Storie raccontate in prima 2
- 3. persona, descrizioni impietose di una quotidianit├Ā fatta di situazioni abitative disumane, in tuguri senza luce e senza acqua, e segnata da fatica e sfruttamento nelle campagne dominate dal caporalato e dal lavoro nero. Ricorrendo alla forma del racconto, il libro d├Ā voce alle storie personali di una comunit├Ā inconsapevole di essere diventata tale. Prendono corpo cos├¼ tante vite invisibili e sbriciolate, ma anche la voglia e il tentativo di delineare proposte e percorsi utili per la costruzione di un progetto di riscatto. Mannaggia la miser├¼a Mannaggia la miser├¼a ├© un esempio emblematico di quanto la narrativa possa costituire un valido ed efficace strumento di denuncia sociale. Anselmo Botte, autore del testo in analisi, articola lo scritto in due parti ciascuna delle quali corrisponde ad un racconto, narrato in prima persona, rispettivamente attribuibili a Bouchaib Hassan, il primo, ed a Mahfoud Aziz, il secondo. LŌĆÖopera si apre con una prefazione di Guglielmo Epifani che, introducendo la tematica successivamente sviluppata, mette in evidenza la necessit├Ā di assumere un atteggiamento solidale nei riguardi dei marocchini di San Nicola Varco, sottolineando lŌĆÖinefficacia delle strategie politiche finora attuate ai fini di una regolamentazione della situazione degli immigrati. Ed ├© proprio questo lŌĆÖobiettivo perseguito, e mirabilmente raggiunto, dallŌĆÖautore: denunciare le barbare condizioni in cui sono costretti a vivere i braccianti della Piana del Sele, riportando non solo ci├▓ che egli stesso ha appurato in quanto attento ŌĆ£osservatore partecipanteŌĆØ, ma anche i racconti diretti di coloro che per fuggire dalla miseria del paese natio si sono ritrovati a dover sopravvivere in un contesto non molto dissimile dal precedente. Nel corso della narrazione, vengono affrontate tematiche di notevole rilevanza sociale che conferiscono allo scritto un carattere ambivalente, di racconto pacatamente descrittivo, da un lato, e di analisi implicitamente sociologica, dallŌĆÖaltro. Oltre alla denuncia, nelle parole di G. Epifani, ŌĆ£lŌĆÖintrecciarsi di queste storie personali fa emergere proposte concrete, come lŌĆÖurgenza di una regolarizzazione per questi lavoratori con lŌĆÖemersione del lavoro sommerso, e la necessit├Ā di un serio impegno per garantire alloggi decentiŌĆØ. Un altro aspetto fondamentale, pi├╣ volte sottolineato dallŌĆÖautore, ├© costituito dallŌĆÖimportanza che per i marocchini di San Nicola Varco riveste quellŌĆÖatteggiamento solidale capace di rendere meno faticoso il lavoro nei campi, pi├╣ tollerabile lŌĆÖafoso caldo estivo, meno pungente il freddo penetrante della notte: la solidariet├Ā costituisce 3
- 4. lŌĆÖunico fattore di conforto per i braccianti. Le descrizioni minuziose e particolareggiate dei luoghi e dei contesti nei quali si svolgono le vicende narrate, alternandosi con veri e propri monologhi interiori dei protagonisti, non sono finalizzate esclusivamente alla critica delle disumane condizioni in cui essi sono costretti a vivere, ma intendono anche denunciare lŌĆÖillegale attivit├Ā di sfruttamento operata dai caporali e dai padroni delle terre: questi, approfittando del bisogno dei marocchini di guadagnare cifre anche irrisorie rispetto alle prestazioni richieste, sfruttando la loro situazione di illegalit├Ā dal punto di vista burocratico e dei permessi, obbligano i braccianti a lavorare incessantemente in cambio di paghe minime nonch├® insufficienti, e ci├▓ avviene nella pi├╣ sconcertante oscurit├Ā e disinteresse da parte delle istituzioni. Il primo racconto, quello di Bouchaib Hassan, marocchino di 26 anni originario di Safi, inizia in un ŌĆ£caldo e umido mattino di luglioŌĆØ. Il protagonista, estremamente preciso nel fornire particolari circa il luogo in cui si sviluppa la vicenda, descrive le ostili condizioni climatiche che rendono il lavoro di raccolta delle pesche ancora pi├╣ faticoso ed estenuante. Dalle modalit├Ā di trasporto sul campo, fino agli argomenti sui quali i braccianti discorrono durante lo svolgimento dellŌĆÖattivit├Ā di selezione dei frutti, vengono esposte tutte le fasi che caratterizzano la giornata lavorativa ŌĆ£tipoŌĆØ di un bracciante della Piana del Sele, il cui unico conforto ├© costituito dalla solidariet├Ā che lo lega agli altri connazionali: ŌĆ£Lavorare a fianco di compagni ├© una cosa ben pi├╣ piacevole che lavorare da soli: ci si incoraggia e ci si conforta. Il sentimento di avere gli stessi nemici, caporali - pesche - caldo, infonde calore e crea comunanzaŌĆØ. A questo punto, il protagonista si sofferma sulla losca figura del caporale. QuestŌĆÖultimo si configura come intermediario tra il padrone dei terreni ed i braccianti; ha come unico obiettivo quello di ottenere il massimo profitto con il minimo impiego di risorse economiche a discapito di quelle umane; ├© quasi sempre anchŌĆÖegli un marocchino che si differenzia dagli altri solo per tempo di permanenza in quello stesso campo e per il rapporto fiduciario che lo lega al padrone. Il caporalato, attivit├Ā illegale estremamente disprezzata da Hassan, ├© alla base del funzionamento delle attivit├Ā di produzione agricola che, a partire dagli anni Novanta, costituiscono un incessante fonte di guadagno per i proprietari terrieri della Piana del Sele. Ai braccianti vengono imposti ritmi di lavoro duri ed insostenibili, in cambio di paghe misere e del tutto insufficienti ai fini del soddisfacimento dei bisogni primari dei lavoratori. Il protagonista, riflettendo 4
- 5. sulla condizione di indigenza in cui ├© costretto a vivere, nota come, pur guadagnando quattromila euro lŌĆÖanno (duecento giornate lavorative con una paga giornaliera di ventitr├® euro), tuttavia non riesca mai ad accumulare alcun risparmio, stentando in talune situazioni ad arrivare alla fine dellŌĆÖanno autonomamente. Lo scenario che fa da sfondo allŌĆÖesposizione di tali contributi ├© quello della descrizione attenta di un turno di lavoro in un sconfinato pescheto. Terminata lŌĆÖattivit├Ā di raccolta, il protagonista ritorna nel campo di San Nicola Varco, definito ŌĆ£ghettoŌĆØ a causa della numerosit├Ā degli abitanti e dellŌĆÖinadeguatezza delle strutture impropriamente adibite ad abitazioni. Egli alloggia in un box il cui ingresso ├© chiuso mediante una parete fatta in lamiera, non ci sono servizi di alcun genere, n├® tantomeno acqua corrente ed elettricit├Ā. Il narratore descrive il tormento che gli provoca lo stare rinchiuso nel suo accampamento durante un afoso pomeriggio estivo: ŌĆ£Questa stanza mi opprime. Un tugurio di cemento di dodici metri quadrati, dal soffitto annerito. Sulle pareti, agganciate a dei chiodi, si stendono quattro corde di spago sulle quali sono appesi gli abiti. Una terza parete ├© fatta in lamiera e chiude lŌĆÖentrata del boxŌĆØ. Terminata la descrizione dellŌĆÖalloggio, Hassan continua con lŌĆÖesposizione delle fasi della sua giornata. Una visita improvvisa al suo vicino, Lharbi Barakat, ├© motivo di un ulteriore conferma da parte del protagonista della disumanit├Ā delle condizioni in cui i braccianti della Piana sono costretti a vivere. Durante il loro breve dialogo, i due compagni discorrono su tematiche di alta valenza sociale che mettono ancor pi├╣ in evidenza lo stato di degrado generale del ghetto di San Nicola Varco. Nello specifico, lŌĆÖattenzione si rivolge al problema del sovraffollamento della struttura cementizia centrale e delle annesse baracche in lamiera, dovuto allŌĆÖimpossibilit├Ā da parte degli immigrati di sistemarsi in normali, seppur modesti, appartamenti nel centro urbano, a causa della sproporzione esistente tra il livello dei prezzi degli affitti richiesti ed il loro effettivo stipendio mensile. Inoltre, il continuo giungere di nuovi marocchini allŌĆÖinterno del campo si spiega in relazione alla necessit├Ā da parte di questi ultimi di fuggire dalla propria patria, nellŌĆÖambito della quale i salari sono estremamente bassi e dove le avverse condizioni climatiche rendono la coltivazione dei campi estremamente faticosa ed infruttuosa. Infine, Hassan racconta a Lharbi lŌĆÖepisodio, verificatosi in quello stesso giorno, della sua richiesta al caporale di un anticipo sullo stipendio, evidenziando ancora una volta la mancanza di umanit├Ā e 5
- 6. comprensione che connota i loro tanto invisi ŌĆ£datori di lavoroŌĆØ. Ci├▓ induce Lharbi ad unŌĆÖamara riflessione sulla crudele natura dei caporali: ŌĆ£Ti buttano via e ti riprendono quando vogliono, devi stare sempre a loro disposizione. Devi dare regolarmente il massimo e anche quando lo dai, non ├© detto che siano contenti. Questi, oltre a sfruttarti, ti fanno sudare sangue e qualche volta ti picchiano pure. E per farti pagare gli devi stare appresso per mesi, la paga te la fanno elemosinareŌĆØ. Al termine della conversazione, dopo una breve passeggiata serale nel ghetto, durante la quale Hassan riflette sulla rumorosit├Ā dello stesso, egli ritorna nel suo box per riposare. Il giorno successivo, non avendo alcun impegno lavorativo, decide di recarsi presso un internet-point per potersi mettere in contatto con la madre. Durante il tragitto, in un significativo monologo sulla sua miserabile condizione, fornisce al lettore un altro dato significativo legato alla pericolosit├Ā del lavoro svolto dai braccianti della Piana del Sele: per la concimazione e la disinfestazione dei campi coltivati, infatti, vengono utilizzati potenti pesticidi, estremamente tossici e nocivi per la salute di chi ├© costretto ad adoperarli, motivo per il quale sarebbe necessario essere muniti di un appropriato equipaggiamento protettivo, quindi guanti e mascherine. Hassan, come prevedibile, afferma che le attivit├Ā che prevedono lŌĆÖimpiego di questi veleni vengono svolte senza alcun tipo di precauzione: ŌĆ£Capita solo raramente, quando lavoriamo sotto le serre per fare i trattamenti chimici, di avere delle mascherine, ma quando lo facciamo a cielo aperto, neanche quelle ci danno. Quei prodotti dove cŌĆÖ├© il teschio, spesso li adoperiamo senza nessuna protezione, a mani nude, respirando a pieni polmoniŌĆØ. Dopo aver fatto riferimento anche al problema della spazzatura e del cattivo odore da essa emanato, giunge allŌĆÖinternet-point. Dopo la consueta descrizione dellŌĆÖambiente e della struttura, espone il contenuto della videochiamata. Hassan, salutata la madre, le chiede come stiano gli altri membri della famiglia, sottolineando che ├© costretto a mentire alla genitrice circa le sue reali condizioni di vita nel salernitano, al fine di evitarle un ulteriore dolore oltre quello provocato dalla scelta migratoria. Dopo circa quaranta minuti di conversazione, la videotelefonata si chiude tra saluti commossi e raccomandazioni a sentirsi presto. LŌĆÖultima sezione di questa prima parte del libro contiene un ulteriore spunto di riflessione sulle dinamiche attraverso le quali i marocchini giungono nella Piana del Sele. La narrazione della vicenda legata alla truffa subita da un compagno del 6
- 7. protagonista introduce un ultimo contributo di Hassan sullŌĆÖirregolarit├Ā dei contratti lavorativi proposti dai caporali, e sul sentimento di delusione che invade gli animi dei marocchini nel momento in cui essi percepiscono di essere stati ingannati: ŌĆ£In questi tre giorni il ragazzo ha capito di essere caduto in un buco nero dal quale non sa come uscire; ├© disperato, tutti i soldi spesi, alla fine faranno di lui un altro clandestino. Tanto valeva salire su un barcone in Libia, con duemila euro ce lŌĆÖavrebbe fatta, sarebbe stato un bel risparmio per lui e per la sua famiglia. Non cŌĆÖ├© differenza tra un clandestino che sbarca a Lampedusa e uno che arriva con il nulla-osta nella Piana del Sele alla ricerca di unŌĆÖazienda inesistente, di un datore di lavoro introvabile, di un caporale che ha staccato il telefono ed ├© sparito dalla circolazioneŌĆØ. La seconda parte del testo ├© dedicata alla trasposizione delle testimonianze di Mahfoud Aziz, bracciante marocchino che alloggia nella seconda palazzina del campo di San Nicola Varco assieme a Chafik Ahmed e Miloud Omar. La narrazione sviluppata dal nuovo protagonista si riferisce ad episodi diversi, verificatisi in differenti contesti geografici, finalizzati a mettere in evidenza aspetti specifici. In questo caso, non viene seguita una sequenza cronologica caratterizzata da linearit├Ā e continuit├Ā, si opta invece per lŌĆÖesposizione di episodi tra di loro sconnessi ma tuttavia legati dalla volont├Ā di celare tra le righe di un semplice racconto, una denuncia sociale accesa e motivata. Nella prima sezione, Aziz si focalizza sulla narrazione dei fatti legati allo sciopero nazionale del 21 ottobre del 2006 organizzato a Foggia dai sindacati. Precedentemente, il 25 settembre 2006, si era tenuto a Salerno uno sciopero organizzato dalla Cgil, per denunciare le gravi situazioni di sfruttamento sul lavoro, il caporalato, le disumane condizioni di vita nel ghetto. Il narratore mette in evidenza lŌĆÖalto tasso di adesioni da parte dei braccianti della Piana, ed il tentativo dei caporali di ostacolare lŌĆÖattuarsi della manifestazione. Si sottolinea lŌĆÖimpatto mediatico ottenuto, ed il notevole coinvolgimento emotivo da parte dei partecipanti. A questo punto, Aziz descrive una fredda giornata di gennaio, trascorsa a lavorare in un campo allŌĆÖaperto per la raccolta di finocchi. Appare evidente lŌĆÖobiettivo di Anselmo Botte, il quale, per la selezione delle testimonianze da riportare nellŌĆÖambito del testo, si serve di criteri di scelta strategici, finalizzati a delineare un quadro completo della situazione dei braccianti marocchini della Piana, per evidenziarne i disagi con i quali essi sono costretti a convivere in tutte le fasi dellŌĆÖanno. 7
- 8. Infatti, mentre la giornata lavorativa descritta da Hassan nella prima parte si collocava nella calda ed afosa stagione estiva, il racconto di Aziz si sviluppa nel gelido e pungente periodo invernale. Il protagonista elenca le difficolt├Ā legate al lavoro da svolgere, precisando che, in questo caso, la paga ├© proporzionale alla quantit├Ā di ortaggi raccolti, strategia, questa, messa in atto dai caporali per evitare di incorrere in eventuali perdite di profitto. Al termine delle otto ore di lavoro, i braccianti rientrano nei loro alloggi per la cena e per trascorrere la notte. Il giorno seguente, Aziz decide di recarsi a Santa Cecilia per effettuare una videotelefonata in modo da mettersi in contatto con Karim, fratello del protagonista, fermamente intenzionato a voler fuggire dal Marocco con la speranza di migliorare la sua situazione economica in Italia. Il raccontare la vicenda legata alla volont├Ā di Karim di emigrare in Italia ha il duplice obiettivo di evidenziare i legami che i braccianti della Piana, nonostante la scelta migratoria, riescono a mantenere con i membri della propria famiglia rimasti nella terra natia, da un lato, e fornire al lettore minuziosi particolari circa le modalit├Ā, spesso illegali, attraverso le quali i marocchini riescono a giungere in Italia, pagando cifre anche molto elevate, dallŌĆÖaltro. Terminata la conversazione, Aziz rientra nel campo e, giunto al suo ŌĆ£accampamentoŌĆØ, si accinge a riordinare il lurido tugurio. Intanto, riflette sulla concezione che i caporali ed i padroni delle terre hanno dei marocchini della Piana del Sele: ŌĆ£Ci chiamano ┬½braccianti┬╗. Ho capito che ai padroni e ai caporali interessano solo le nostre braccia, ma questa parola ci annulla come esseri umani. Qui lo chiamano ┬½il mercato delle braccia┬╗ ed ├© forse anche per questo che molte volte siamo definiti ┬½invisibili┬╗. Le braccia isolate dal corpo cosa sono?ŌĆØ. La narrazione prosegue con la descrizione di una tipica domenica di gennaio, trascorsa a riordinare lŌĆÖalloggio, a cucinare e ad effettuare compere presso il piccolo bazar costituitosi nel tempo nel cuore della Piana. Questa sezione ├© dedicata allŌĆÖesposizione delle modalit├Ā di gestione della sfera domestica da parte degli abitanti del ghetto, mediante il riferimento alle attivit├Ā di pianificazione collettiva e di organizzazione interna del campo. Si sottolinea ripetutamente lŌĆÖatteggiamento solidale che connota ciascun membro della comunit├Ā, in termini di assistenza reciproca tra compagni: ŌĆ£In tutti ci sar├Ā il ricordo di un periodo vissuto in una condizione disumana, 8
- 9. ma dentro un ambiente di fratellanza. Le porte dei nostri rifugi sono aperte e si offre volentieri il pasto al vicino, allŌĆÖamicoŌĆØ. Dopo aver consumato il pranzo, il protagonista, assieme ai suoi compagni di ŌĆ£stanzaŌĆØ, decide di recarsi a Battipaglia, al fine di trascorrere un pomeriggio in maniera differente rispetto alla solita e monotona routine settimanale. LŌĆÖincontro con due anziani del paese funge da pretesto per lŌĆÖindicazione delle motivazioni che hanno indotto i proprietari delle terre della Piana del Sele ad una continua ed ininterrotta ricerca di manodopera a basso costo, per riuscire a soddisfare le richieste e le pretese delle grandi multinazionali: ŌĆ£Una delle pi├╣ grandi del mondo nel settore agroalimentare, la Bonduelle, ha uno stabilimento a pochi chilometri da qui. Sono questi colossi che hanno rovinato tutto, con i loro contratti capestro nei confronti dei produttori, che a loro volta applicano salari ancora pi├╣ da capestro a noiŌĆØ. Giunta la sera, il gruppo ritorna al campo. LŌĆÖultima sezione di questa seconda ed ultima parte del libro in analisi ├© dedicata a Toufik Brimila, marocchino giunto a San Nicola Varco nel 2002, che, spinto dallŌĆÖinteresse nei riguardi delle storie di vita dei suoi connazionali, realizza uno scritto di centosessantotto pagine, in arabo, estremamente curato dal punto di vista stilistico e ricco di particolareggiate descrizioni. LŌĆÖopera, lasciata in copia dal suo creatore presso la moschea del campo perch├® fosse consentito a tutti di leggerla, costituisce una valida ed esemplare testimonianza scritta del triste passato, del tragico presente e dellŌĆÖincerto futuro degli abitanti del ghetto di San Nicola Varco, poich├®, nelle parole del narratore, ŌĆ£riesce a delineare perfettamente il profilo psicologico dei personaggi, il loro progetto migratorio, la loro posizione allŌĆÖinterno del ghetto, le caratteristiche dei piccoli gruppi, che si creano per la condivisione dello spazio abitativo o delle giornate di lavoroŌĆØ. Seguono due appendici iconografiche intitolate I volti, la prima, ed I luoghi, la seconda, contenenti fotografie rispettivamente di Tommaso Bonaventura ed Anselmo Botte, finalizzate a fornire al lettore testimonianze visive di quanto precedentemente descritto nel corso della narrazione. AUGUSTO COCORULLO - UNIVERSIT├Ć DEGLI STUDI DI NAPOLI ŌĆ£FEDERICO IIŌĆØ - DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI - DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE SOCIALI E STATISTICHE - XXIX CICLO 9
- 10. ma dentro un ambiente di fratellanza. Le porte dei nostri rifugi sono aperte e si offre volentieri il pasto al vicino, allŌĆÖamicoŌĆØ. Dopo aver consumato il pranzo, il protagonista, assieme ai suoi compagni di ŌĆ£stanzaŌĆØ, decide di recarsi a Battipaglia, al fine di trascorrere un pomeriggio in maniera differente rispetto alla solita e monotona routine settimanale. LŌĆÖincontro con due anziani del paese funge da pretesto per lŌĆÖindicazione delle motivazioni che hanno indotto i proprietari delle terre della Piana del Sele ad una continua ed ininterrotta ricerca di manodopera a basso costo, per riuscire a soddisfare le richieste e le pretese delle grandi multinazionali: ŌĆ£Una delle pi├╣ grandi del mondo nel settore agroalimentare, la Bonduelle, ha uno stabilimento a pochi chilometri da qui. Sono questi colossi che hanno rovinato tutto, con i loro contratti capestro nei confronti dei produttori, che a loro volta applicano salari ancora pi├╣ da capestro a noiŌĆØ. Giunta la sera, il gruppo ritorna al campo. LŌĆÖultima sezione di questa seconda ed ultima parte del libro in analisi ├© dedicata a Toufik Brimila, marocchino giunto a San Nicola Varco nel 2002, che, spinto dallŌĆÖinteresse nei riguardi delle storie di vita dei suoi connazionali, realizza uno scritto di centosessantotto pagine, in arabo, estremamente curato dal punto di vista stilistico e ricco di particolareggiate descrizioni. LŌĆÖopera, lasciata in copia dal suo creatore presso la moschea del campo perch├® fosse consentito a tutti di leggerla, costituisce una valida ed esemplare testimonianza scritta del triste passato, del tragico presente e dellŌĆÖincerto futuro degli abitanti del ghetto di San Nicola Varco, poich├®, nelle parole del narratore, ŌĆ£riesce a delineare perfettamente il profilo psicologico dei personaggi, il loro progetto migratorio, la loro posizione allŌĆÖinterno del ghetto, le caratteristiche dei piccoli gruppi, che si creano per la condivisione dello spazio abitativo o delle giornate di lavoroŌĆØ. Seguono due appendici iconografiche intitolate I volti, la prima, ed I luoghi, la seconda, contenenti fotografie rispettivamente di Tommaso Bonaventura ed Anselmo Botte, finalizzate a fornire al lettore testimonianze visive di quanto precedentemente descritto nel corso della narrazione. AUGUSTO COCORULLO - UNIVERSIT├Ć DEGLI STUDI DI NAPOLI ŌĆ£FEDERICO IIŌĆØ - DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI - DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE SOCIALI E STATISTICHE - XXIX CICLO 9